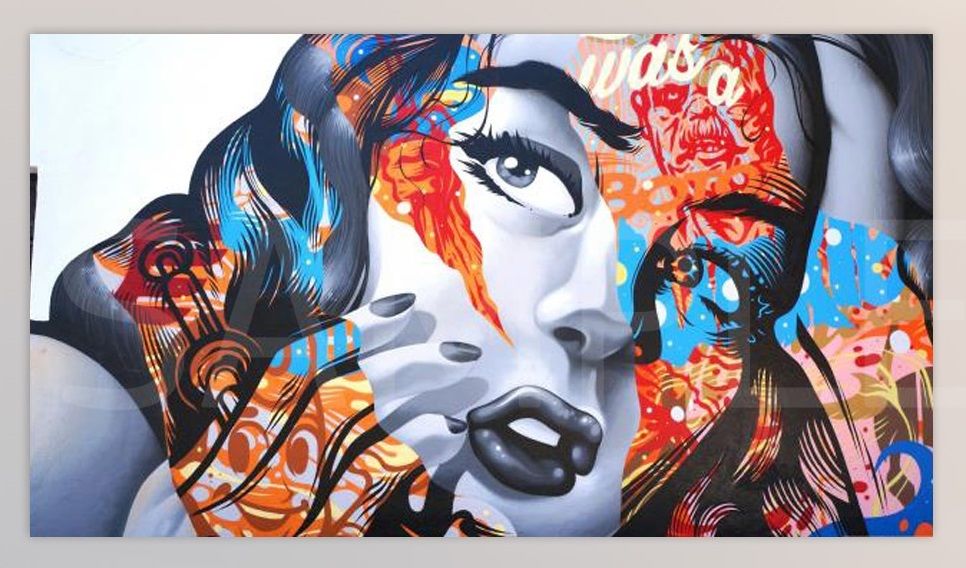Al Gran Bazar di Jack Lo Squartato_Mario Ventrelli, Montescaglioso(MT)
_Racconto vincitore seconda edizione Premio Energheia_1994.
(Breve prefazione a cura del prof. Daevid Allen dell’Università di Honolulu)
È passato esattamente un secolo da quando, in un oscuro garage di Lione, i fratelli Lumiere proiettarono le prime immagini in movimento davanti ad uno sgomento gruppo di spettatori. Trent’anni più tardi Jack Kowalsky faceva la sua prima apparizione sul grande schermo provocando altrettanto stupore. Questi due straordinari avvenimenti, degni di uguale attenzione, sono in questi mesi oggetto di approfonditi convegni e pubblicazioni. Ci sembra quindi doveroso offrire il nostro giusto apporto alle celebrazioni. Non è il caso di spendere una sola parola in piùsullo stile “ultra noir” del suo cinema e sulla sua leggendaria arte di arrangiarsi. In occasione dell’insulso kolossal che Hollywood sta reparando per celebrare Kowalsky (si parla insistentemente di Schwarzenegger: al suo Terminator preferiamo Godzilla), presentiamo con parsimonia di mezzi un breve racconto sicuramente improntato ad una più coerente verosimiglianza biografica. Ci auguriamo possa avere il riconoscimento sperato e che, inoltre, possa gettare una nuova luce sulla sua inspiegabile morte e sulla sua mitica Ultima Sequenza.
*
Bei tempi quelli del boss Johnny Torrio a New York. In strada si sparava a ritmo di Charleston ed un becchino che sapeva farci poteva imbarcare soldi come un petroliere: anche tra i cipressi poteva avverarsi il grande Sogno Americano. Il più in gamba di tutti era Jack Kowalsky: ancora trentenne, nel 1929 gestiva con fiuto un florido cimitero a Central Park. Amante dello stile e del buon gusto, Jack forniva i suoi clienti di bare di tutti i colori e di tutte le forme, dall’armadio alla botte, dal grazioso formato talamo, sino al modello Duchamp a forma di sommergibile. Un ragazzo a posto si sarebbe detto, se non fosse stato per il fatto che nel giro di ventiquattrore i defunti si vedevano portati a prematura resurrezione. Quindi, dopo una lunga corsa notturna, scaraventati direttamente negli uffici della casa produttrice di film polizieschi Jena Picture. Ancora ignari del loro destino, i nuovi arrivati venivano ripuliti e rimessi in sesto alla meglio, per finire il loro viaggio in uno dei vari studios, a fare da degno sfondo alle gesta dei gangsters. I più fortunati venivano ripresi in Primo Piano, eletti così a fama eterna, giusto premio per una vita di sacrifici. Sotto la direzione di Kowalsky, la Jena Picture realizzava in economia film torbidi per le grandi Majors di Hollywood e con la crisi che cera, bisognava pure arrangiarsi. Jack dirigeva quei film con la rapidità del fulmine mal sopportando, le sue comparse, il calore dei riflettori. Del montaggio si occupava invece, a colpi di pesto e mannaia, un macellaio di Brooklyn. Con mano ferma, Jack annotava su di un taccuino tutto ciò di cui Hollywood avesse bisogno: bianchi o neri, rabbini o jazzisti per lui non faceva differenza. New York è sempre stata un serbatoio inesauribile ed egli non aveva che l’imbarazzo della scelta. Per la serietà e l’affabilità nel piazzare i suoi articoli si poteva paragonare ad un concessionario di automobili. La sua fiorente industria aveva puntato al riciclaggio ancor prima che alla Ford ne avessero teorizzato l’utilità. E con che risultati! Se è vero che taluni artisti conoscono la fama solo dopo morti, cosa avrebbe dovuto dire Serge Devigny? Incompreso attore di film del terrore, durante la sua grigia esistenza non era mai riuscito ad avvicinare il suo ceffo a meno di venti metri dalla macchina da presa, relegato al ruolo di squallida comparsa. Ma grazie a Kowalsky nessuno dimenticherà mai la sua intensa espressione con una pallottola piazzata in fronte nel memorabile finale di Death Row (Braccio della morte). Il viso putrefatto, gli zigomi ossuti, il ghigno terrificante dei suoi denti marci fecero vomitare milioni di americani, facendo impallidire il mito di Lon Chaney. Come ogni buon talent scout, Jack disponeva, di un ben ordinato archivio fotografico. Vi comparivano tutti i defunti piùfreschi e dettagliate informazioni sui malati terminali di Manhattan. La sua fama doveva già allora essere notevole, se a vario modo i morituri se ne contendevano le attenzioni. La speranza dell’immortalità nel cinema alleviava le pene del trapasso ed offriva più garanzie di quelle offerte dai vescovi.
Kowalsky, in fondo, si considerava un benefattore. Infatti, quello che poteva sembrare l’hobby sconsiderato di un cinico, era invece l’atto filantropico di un grande utopista. Filmando i trapassati, Jack intendeva sottrarli all’abbraccio della morte che tutto oscura, per dare loro imperituro asilo nell’Olimpo della celluloide. Altrimenti, diceva, cosa sarebbe rimasto di loro? Nient’altro che una pallida foto su di una lastra di marmo, sepolti nelle sabbie del passato. Perché, diceva sempre il becchino, è questa la vera tragedia della morte: l’oblio a cui ci condanna, il dover scomparire per sempre dalla memoria degli uomini. Ma quello che più interessava Jack, era progettare la sua vita affinché un evento memorabile lo consegnasse ai posteri. Perché la vera sfida alla morte può risiedere proprio in un gesto, in una intuizione geniale, capace di moltiplicare il nostro ricordo nei secoli. Come esempio Kowalsky amava citare Goethe e Renoir, Kant e Jack Dempsey, la cui memoria rimarrà intatta in eterno. Proprio per questo aveva progettato, a coronamento della sua ambiziosa missione, di filmare in diretta la sua morte, così da beffarsi di essa e divenire immortale nel momento stesso del suo fatale abbraccio. Il suo Dio era dunque il cinema e i suoi discepoli in terra Chaplin, Dreyer e Feuillade. Emblema della sua chiesa era la cinecamera: ogni sua molla, ogni suo ingranaggio, la gelida pupilla del suo occhio di vetro erano per lui sacri.
Le sue risorse umane dovevano essere leggendarie e questa fama giunse anche alle orecchie di Mervyn Le Roy, grande regista di gangster movies in quei giorni a New York per girare Piccolo Cesare. Jack aveva sentito molto parlare di quell’uomo ed inoltre sapeva che nel film avrebbe lavorato un mito: Edward G. Robinson. Fu così che, quando gli arrivò una lettera dello stesso Le Roy, gli parve di non credere ai suoi occhi. Dopo i vari convenevoli, vi compariva la descrizione accurata del defunto che cercava per la parte dello sbirro impallinato alle spalle. Altezza 1.90, secco come una scopa, viso allungato a tubo di scappamento (preferibilmente General Motors), occhi piccoli con sopracciglia cespugliose e naso a civetta da iettatore. La lettera terminava con un oscuro post scriptum firmato di suo pugno da Rico Cazzullo, pluri omicida e temuto boss della produzione arricchitosi proprio con i gangster movies. Cazzullo concedeva una settimana per scovare il defunto, onde evitare assai spiacevoli conseguenze. Jack controllò accuratamente i suoi cataloghi ma realizzò subito con grande disappunto di non avere sottomano quel genere di articolo. Ricordava però di aver già visto da qualche parte quella faccia da patibolo e questa sgradevole sensazione lo accompagnò per tutta la notte, facendogli fare sonni inquieti. Ma fu solo radendosi che la mattina seguente venne a capo del mistero. Mentre la sua pelle ruvida emergeva da una montagna di schiuma, Jack si accorse di somigliare sempre più a quella descrizione. Ed ogni nuova rasoiata gli confermava quella sgradevole impressione. Si fissò a lungo incredulo nello specchio come Spencer Tracy in Dottor Jekyll. Cosa significava questo? Era dunque un avvertimento della mafia? A chi aveva potuto pestare i piedi? Che volessero toglierlo di mezzo? Impossibile, non aveva ancora deciso di morire. Jack si convinse che doveva trattarsi solo di una spiacevole coincidenza. Del resto ci teneva a non perdere quell’occasione: Piccolo Cesare avrebbe potuto aprirgli definitivamente le porte del grande cinema. Trangugiata una bottiglia di bourbon, scese quindi in strada alla disperata ricerca di un sosia da accoppare. Ecco come descrisse quei giorni in una celebre intervista sui “Cahiers”.
-Trentasei ore dopo scovai finalmente il tipo che faceva per me. Ted Rea, giudice a Chinatown. Di modi raffinati, differiva dall’identikit solo per la statura, essendo alto come un copertone. Ma a New York, per compiere un delitto, bisognava superare l’esame della Murder Incorporated. Questo sindacato al quale aderivano incondizionatamente tutti i gangsters, era stato fondato per tutelare l’immagine e gli interessi della categoria. Così, affinché un omicidio superasse la verifica, era necessario che fosse ben progettato, esteticamente apprezzabile, armonioso ed eseguito con stile e buon gusto. La dura selezione, avrebbe così costretto l’aspirante archibugiere a delegare i suoi loschi propositi all’Onorata Società assicurandosi, dietro pingue compenso, un lavoro pulito e senza sbavature. Senza lo straccio di un’idea, tentai il tutto per tutto. Delegato per la mia zona era un certo Lazslo Zukov che trattava i suoi affari dietro il paravento di un negozio di strumenti musicali. Procuratomi l’indirizzo, soprabito alla mano, presi quindi un taxi per SoHo. Sulla 6th Avenue, mi infilai in un vicoletto poco illuminato. Il negozio, rischiarato da una debole lampada a gas, corrispondeva alla descrizione in mio possesso. Aperta la porta, ebbi la mia prima sorpresa: si trattava sì di strumenti, ma di quelli calibro 38 usati per suonare ai funerali. Una cappa densa di fumo appestava l’aria. Seduto su di una sedia impagliata, il mio uomo ascoltava assorto gli scoppiettii curiosi di un grammofono. Sembrava non essersi accorto della mia presenza.
“Mr. Zukov?” L’uomo si levò in piedi e mi squadrò come si fa con una cambiale.
“Desidera?”
“Ammazzare il giudice Rea”, feci io con tono sicuro.
“Bravo, ragazzo. Mi piacciono i tipi ambiziosi, ma lei non ha esattamente l’aspetto di un professionista e per cominciare a tirare di spingarda un giudice è un bersaglio un po’ troppo grosso. Avanti, mi dica, ha qualche titolo? Qualcosa nero su bianco? Una condanna, per esempio, ha una condanna? Qualche omicidio, un attentato, un’estorsione? Avrà pure un curriculum”.
“Ehm, no, purtroppo no…”
“Mi mostri almeno un piano, un abbozzo, uno schema. Due righe…”
“Veramente non ci avevo ancora pensato…”
“Grave, molto grave. Ma cosa pensa che progettare un omicidio sia come prepararsi un ovetto? Un omicidio è un’opera d’arte e…” improvvisamente si fece silenzioso.
“La sente? La sente questa musica?”, Zukov mi indicava il grammofono. Ma a parte una sequela immonda di rumori, non sentivo alcuna melodia:
“La sente? È l’assalto alla centrale del latte di Dillinger. Musica per le mie orecchie. Una sinfonia per mucca e nitroglicerina. E quest’altra? Il concerto per una mano sola di Mayer Larsky alla First National Bank. Una composizione degna di Ravel. Come vede, noi gangsters siamo prima di tutto dei musicisti”. Zukov aveva senz’altro dei gusti colti e raffinati. Guardando meglio trai suoi dischi scovai l’opera omnia di Johnny Torrio ed un pregevole Live in S. Quintino. Il mio uomo sembrava decisamente su di giri. Tirò fuori alcune pistole e la mappa di quella che sembrava essere la City Bank. Me la mise sotto il naso.
“Questi sono i nostri spartiti. E questi gli strumenti con cui li suoniamo. Tra le mani di un professionista una “Smith & Wesson”diventa un violino. E dunque, lei ha mai udito un principiante suonare Paganini? Cosa ne verrebbe fuori?” Ero interdetto. Cercai in qualche maniera di accendermi una sigaretta.
“Ora le mostrerò una cosa. Mi guardi bene, così, di profilo. Segua la dolce curvatura del naso, le adorabili froge equine, il mento sporgente ma non volgare. Non le ricordo Caruso? Con 5000 $ garantisco al suo giudice un concerto indimenticabile. Avanti, ha qualche suggerimento? Un motivetto, una melodia daproporre? Suvvia, non faccia il timido…”
Ne avevo abbastanza. Tirai fuori il mio clarinetto e gli suonai una marcia funebre. L’idea dovette sembrargli fulminante. Come le cinque pallottole che gli ficcai in corpo.
Disteso in mutande sul mio letto, meditai per due giorni di seguito. Avevo il morale sotto le suole. La settimana a mia disposizione era ormai finita e fare un bidone a Rico Cazzullo significava scavarsi la fossa con le proprie mani. Destino curioso per un becchino. Una volta per commettere un omicidio era sufficiente un po’ di buona volontà. Oggi, anche per far questo, bisogna staccare un assegno. Quanto ci avrebbero messo i suoi uomini a scovarmi? Avevo appena acceso una sigaretta quando un formidabile calcio buttò giù la porta. Quattro individui con mitra mi si pararono davanti. Quello col cappello grigio avanzò di un metro e guardandomi negli occhi mi urlò sul muso: “C’mon, Jack!” –
Il Lunedì seguente, 3 luglio 1930, dopo una semplice cerimonia, Jack Kowalsky fu calato nella fossa in una solida bara di quercia. Un venticello leggero fischiava tra i pioppi ed increspava l’acqua delle pozzanghere. Una platea distratta assisteva al rito sbrigativo, scrutando nervosamente il cielo grigio carico di nubi temporalesche. Un’afa soffocante incendiava l’aria ed i pochi presenti si chiedevano quanto accidenti sarebbe durata ancora quella cerimonia. La stessa cosa si chiedeva Jack sottoterra in un bagno di sudore. Quella mattina, travestito da sbirro, era stato già sepolto e dissotterrato quattro volte e, se non si decidevano a girare come si deve quella benedetta scena, avrebbe finito per rimetterci veramente le penne dal caldo: inutilmente cercava di farsi vento con un crisantemo. Ma tutto sommato non aveva di che lamentarsi. Quando gli sgherri portarono Jack nel loro covo, a Cazzullo gli venne un mezzo colpo. La somiglianza con l’uomo che cercava era impressionante. Kowalsky gli poteva tornare utile e gli fece salva la pelle a patto che accettasse di farsi accoppare sul set. E la sua interpretazione fece molto scalpore.
Nel campo del cinema il nome di Rico Cazzullo contava quanto quello di Cecil B. De Mille. Il secondo era stato un alfiere della commedia brillante quanto il primo del gangster movie. Secondo alcuni, Cazzullo era stato addirittura il fondatore del genere. E chi meglio di un gangster poteva raccontare un’invasione? A settant’anni suonati, per lui quei film avevano soprattutto il sapore del ricordo: uno specchio dentro il quale veder riflessa la sua giovinezza di mariolo immigrato da Catania. Seduto al cinema, il mento posato su di un bastone, gli capitava spesso di commuoversi dinanzi ad una rapina o ad una semplice coltellata. Era tutto quanto potesse concedersi. Ma ultimamente qualcuno gli stava rovinando il giocattolo. In là con gli anni, aveva incautamente affidato quel business a Nick Astro, uno squinternato regista che, secondo i bene informati, con i suoi fiaschi aveva contribuito alla Grande Crisi del ‘29. Cazzullo non vedeva l’ora di liberarsi di lui e, tra una sparatoria e l’altra, fece in modo che un confetto gli capitasse per caso nel cranio. Chiamato in causa per occultare il cadavere, Jack fece del proprio meglio e Nick scomparve nottetempo attraverso la tazza del water. In segno di ringraziamento per quel lavoro, Kowalsky fu accoltellato per ben ventiquattro volte con grande delizia dei critici e del pubblico. Inaspettatamente, cominciava infatti ad incuriosire quel faccia da necrologio buono solo a farsi stendere e presto, bruciando tutte le tappe, Jack divenne famoso come “Il defunto che tutti vorreste avere”
Memore dei fasti della Jena Picture, il boss conosceva bene l’inconomicità e la genialità delle produzioni di Kowalsky, ed in breve gli diede carta bianca riguardo ai copioni da scegliere. Ma pur lusingato da questa inattesa svolta nella sua carriera, Jack decise di limitare le sue apparizioni a pochi fotogrammi, giusto il tempo di tirare le cuoia. Decisione che però non gli impedì di mettere a segno alcune clamorose interpretazioni. La sua stravagante performance in Scarface del 1932, ne segnò la definitiva consacrazione a stella del cinema. Il film, diretto da H. Hawks, si avvaleva del prezioso lavoro di Paul Muni e di Boris Karloff. Ebbene, i gangster trucidati la notte di San Valentino avevano un solo volto, quello di Kowalsky. In un’unica inquadratura, grazie ad un semplice trucco, Jack morì ben otto volte. Molti anni dopo, scrivendo su quel film, Jean-Luc-Godard osservava che “Se la fotografia perpetua l’istante, il cinema filma la morte al lavoro” Divenuto celebre, Jack era però roso dal dubbio. Quella carriera come morituro poteva gettare una luce di ambiguità sull’unica, memorabile scena che si apprestava a girare: la sua morte in diretta. Ma, aveva bisogno del successo per rendere indimenticabile quel gesto, e se il destino aveva deciso di farglielo guadagnare in quel modo, ebbene, lui sarebbe stato al gioco.
Il film successivo fu Vroom, ispirato alla vita di Frank Costello. La pellicola fu preceduta da un battage pubblicitario senza precedenti. Nella scena madre, mentre gli infilava un attizzatoio nell’orecchio, Richard E. Grant sussurrava suadente: “Ti torturerò così lentamente che morirai sbadigliando”.
Al botteghino fu un successone. Jack venne fatto fuori quattordici volte con ogni tipo di arnese: dall’ascia alla forca, dall’archibugio al ferro da stiro, fino ad un souffllè a base di aglio. Per questa interpretazione, Kowalsky divenne universalmente famoso come “Jack lo Squartato” Sui set americani, non vi era ormai omicidio in cui la sua presenza non fosse ritenuta essenziale. Come egli stesso ebbe ad affermare nel 1934:
“Nel giro di pochi anni fui accoppato dai più grandi divi di Hollywood, da James Cagney a Humphrey Bogart, da Cary Grant a Douglas Fairbanks. Certo, non sarò Buffalo Bill, ma non ho sbagliato un colpo.”
Più o meno nello stesso periodo, la Winchestar, casa leader nella produzione di armi, scelse Kowalsky come uomo immagine per promuovere il suo nuovo fucile a pallettoni.
Astutamente consigliato dai suoi manager, Jack seppe creare intorno a sé un’aura fantastica, ispirandosi nei suoi vestiti al romantico protagonista di Za la mort. Così, pur non favorito da un fisico irresistibile, prese a farsi vedere in giro in camicia scurissima, fascia alla vita, berretto con visiera lucida, pantaloni attillatissimi, sigarette sottili come spilli. Ed in questa foggia egli arrivò al festival del cinema di Londra nel 1935. Jack presentò in concorso un’opera assai ambiziosa intitolata: Il vuoto inclinato, scritta in collaborazione col poeta intransitivo Franco Sciscio. Di impianto fortemente sperimentale, l’opera rivelò una vena lirica del tutto sconosciòta nel suo autore: la fotografia densa di poetici chiaroscuri, si avvaleva della supervisione di Man Ray. Per tutta la durata del film, la cinecamera era posta direttamente nella bara e, benché l’impresa si presentasse assai ardua, il risultato fu veramente sorprendente. Visto con gli occhi di un defunto, il mondo assumeva un’atmosfera elegiaca. Anche l’atto più insignificante come il passeggiare o il raccogliere un fiore, si caricava di insospettata poesia. Qual era il messaggio che Jack volle lanciare agli uomini? Forse anticipare la drastica decisione che avrebbe preso di lì a poco? O forse prendere le distanze da un mondo che vedeva sempre più estraneo? In ogni caso, i giudizi furono molto contrastanti. L’inquadratura era forzatamente fissa, onirica, ed i piùmaliziosi affermarono che in realtà, steso nella cassa da morto, Kowalsky ronfò per tutta la durata delle riprese. Come il pubblico al cinema, del resto. Il New York Times, argomentando sull’inedito punto di vista di quel film, ebbe per la prima volta a parlare di cinema underground. Ma il passo era troppo ardito e se in Europa furono perplessi, Cazzullo visse questo nuovo corso come una pugnalata al duodeno. Cosa che ci si doveva aspettare da uno che di omicidi se ne intendeva. Il vecchio lo invitò a non fare pazzie, non voleva ritrovarsi sul lastrico a settantacinque anni. In cuor suo Jack era disorientato, ma non voleva rovinarsi la reputazione, proprio ora. Così, in segno di ravvedimento, dichiarò al boss che era disposto a fargli riguadagnare i suoi dollari girando un film retrospettivo su tutta la sua carriera. Cazzullo prese l’occasione al volo, ma solo a patto che l’opera fosse consegnata non oltre la mezzanotte dell’otto marzo, ovvero dopo due mesi. Aveva bisogno al piùpresto di capitali freschi. Jack non stava più nella pelle: benché la scadenza fosse invero temibile, questa decisione spianava la strada alla realizzazione del suo ambizioso disegno: filmare la sua morte in diretta. Il piano era semplice e lineare: ripercorrere in un lungometraggio di un’ora e mezza tutto il meglio che aveva girato nella sua fulminante carriera. Una sequela immonda di omicidi, accoltellamenti e torture da far impallidire Scotland Yard. L’ultima sequenza avrebbe però contenuto, all’insaputa dello stesso Cazzullo, la sua morte, quella vera, inoppugnabile. L’ora era ormai matura: stavano arrivando i primi capelli bianchi e la pancia cominciava a farsi sentire. Al suo supremo appuntamento, Jack ci teneva, invece, ad arrivare in piena forma, come uno sposo sull’altare. Finalmente, com’inra suo sogno, in un sol colpo avrebbe dato l’addio estremo alla vita ed al cinema. Registrando il suo decesso sulla celluloide, egli si preparava così ad unirsi a tutti gli altri Jack morti nei suoi film. E ricongiungendosi con essi, ambire quindi all’immortalità.
L’appartamento di Kowalsky, a Central Park, era fresco ed accogliente. Una miriade di suoi primi piani campeggiava sui muri, in pose così sofisticate da ricordare Gloria Swanson in Viale del tramonto. In fondo alla sua camera, una grossa cinepresa montata su treppiede inquadrava uno sgabello rosso ed un grande orologio a pendolo. Accomodato su quello sgabello Jack sarebbe passato a miglior vita entro mezzanotte dell’otto marzo. Pochi minuti dopo, un notaio di sua fiducia avrebbe ritirato quella sequenza e l’avrebbe consegnata a Cazzullo insieme a tutto il resto del film. Ma perché il suo gesto ottenesse l’inffetto desiderato, era necessario che Jack si desse la morte in una maniera mai fatta prima. Nella sua scena madre ci teneva a non passare come plagiatore, specie di se stesso. Lavorando sodo, egli trascorse quindi una settimana da sogno: a pochi attori era stato concesso di morire sul palcoscenico. Ma, montata la prima parte del film, uno sgradevole contrattempo interruppe quell’atmosfera idilliaca. Visionando la pellicola, Jack si accorse di aver girato piùdi millecinquecento varianti sul tema omicidio e, per quanto si sforzasse, non riusciva ad immaginarne di nuove. Se all’inizio questo piccolo intoppo non aveva fatto altro che stimolare ancor di piùla sua fantasia, alla lunga la cosa divenne piùseria di quanto avesse previsto, dandogli parecchi pensieri. Evidentemente si era un po’ sopravvalutato. Qualsiasi suo gesto, dal grattarsi allo sturare il lavandino, offriva lo spunto per una possibile soluzione subito frustrata dalla perfezione impietosa di quella pellicola. La progettazione di quella scena tenne impegnato Jack nelle ultime due settimane. Una lettera allarmata di Cazzullo, l’invitò a fare avere sue notizie. In un mese aveva avuto due infarti e ci teneva a sapere che il suo becchino stesse bene. Ma nel giro di pochi giorni, l’umore di Jack peggiorò visibilmente. Visionando accuratamente fotogramma per fotogramma quel film, aveva ormai realizzato che non mancava assolutamente niente. Per quanto i suoi disegni divenissero sempre piùcomplessi, essi trovavano in quella pellicola un antecedente piùo meno fedele. Ad un passo dalla realizzazione del sogno di una vita, quella storia gli pareva inaccettabile. Ma sebbene l’otto marzo si avvicinasse pericolosamente, Jack non intendeva venir meno alla clausola della sua morte. Gli altri Jack appesi al muro l’osservavano, con uno strano ghigno, aggirarsi rimuginante in quella casa. Ormai ridotto ad uno straccio, decise di scendere in strada e consultarsi urgentemente con un medico. Ma non per farsi curare. Seduto nel suo ambulatorio, l’uomo in camice bianco sembrava non capire:
“La scongiuro, mi aiuti a morire, solo lei può darmi l’idea giusta!” Nel dir questo, Jack guardava con occhi spiritati la miriade di veleni, forcipi, tenaglie e tutto quanto faceva parte del suo armamentario.
Il cerusico cercò di farlo ritornare in sé, ma Jack si prostrò ai suoi piedi supplicandolo:
“Suvvia, non sarà la prima volta che spedisce qualcuno all’inferno!” A quel punto, si convinse che fosse da rinchiudere e chiamò ad alta voce due infermieri ma, raccogliendo tutte le sue forze, Jack riuscì a divincolarsi e, bestemmiando ferocemente, saltò dalla finestra facendo perdere le sue tracce. Quello strano episodio sollevò molti interrogativi circa lo stato mentale di Kowalsky e nei giorni seguenti i giornali ebbero ad interrogarsi se non fosse stata tutta una montatura pubblicitaria.
Intanto, chiuso nel suo appartamento, Jack sfogliava avidamente una voluminosa enciclopedia alla ricerca di nuove idee. Una fulminante intuizione lo tirò fuori per un attimo dall’angoscia: pagare qualcuno per farsi uccidere. Ma purtroppo questa variante occupava la stragrande maggioranza del suo film. Una possibilità ancora inesplorata era però quella dell’utilizzo di una piccola cerbottana al curaro in uso presso certe tribù australiane che Jack vedeva fedelmente riprodotta su quell’enciclopedia con grande minuzia di particolari. Il suo effetto era letale e le possibilità di sopravvivenza praticamente nulle. Ma chi avrebbe dovuto eseguire materialmente quell’omicidio? Con più tempo a disposizione, non avrebbe esitato a recarsi a Sidney per cercare personalmente un assassino desideroso di visitare Long Island, ma ormai non gli restavano che quarantott’ore. Iniziò quindi a congetturare su quante possibilità avesse di strozzarsi con le proprie mani: ne aveva una gran voglia.
In questo stato, Jack si trascinò fino allo sgabello la notte fatidica dell’otto marzo, dopo aver avviato la cinepresa. Erano le 23,55. Come in un duello, da una parte Jack, le spalle curve e lo sguardo spento. Dall’altra, irta su di un treppiede, la cinepresa lo fissava negli occhi, pronta a coglierne ogni singolo movimento. Il suo ronzio impaziente agitava l’aria. Il capo riverso, la bocca spalancata, Jack era completamente immobile. Solo un leggero tremolio alle gambe. L’orologio scandiva il tempo impietoso ed ogni secondo che passava lo spingeva nel baratro del suo fallimento. Fuori, in un’atmosfera surreale, la luna imbiancava i grandi platani di Central Park, moltiplicandosi nell’acqua dei suoi laghi.
Poi, improvvisamente, allo scoccare della mezzanotte, un urlo agghiacciante. In un balzo spaventoso Jack si avventò sulla cinepresa, iniziando a divorarla furiosamente. Giù! Giù! Sempre più giù, trascinandosi a terra, lottando sotto i tavoli, avvinghiati in una lotta mortale senza esclusione di colpi. Poi, mentre sembrava stesse soccombendo, scansando un disperato fendente, finse un attacco alle manopole e piazzò un montante alle valvole. La mattina dopo, avvisata da alcuni vicini di casa, la polizia fece irruzione nel suo appartamento. Il caos regnava sovrano. Gli specchi rotti, le tende strappate, i tavoli fracassati, indicavano che la furiosa colluttazione doveva essere durata almeno venti minuti con alterne vicende. Infine, nella camera da letto, l’ultimo ghigno di Kowalsky. Lo sguardo trionfante, giaceva esanime accanto alla finestra: il ventre ingrossato ed un voluminoso treppiede che gli usciva dalla bocca.
Il 6 giugno 1937, al festival del cinema di Minneapolis, Jack ricevette un prestigioso Oscar alla memoria tra l’ovazione unanime di pubblico e critica. “Ad uno dei più grandi inventori del secolo” era scritto nelle motivazioni. “Le sue funamboliche interpretazioni lo hanno reso immortale. La sua arte istrionica ed il suo spirito combattivo, resteranno eternamente scolpiti nei nostri cuori”. Le cronache narrano che il suo ultimo film non venne nemmeno citato poiché, a detta dei critici, monotono, privo di suspense ed inutilmente auto celebrativo. In quanto alla famosa ultima sequenza, dovettero estrargliela dal sedere. Ed era una sequenza di merda.