Luca Rastello: “La mia verità su I Buoni”_ospite a Matera venerdì 13 settembre 2014.
I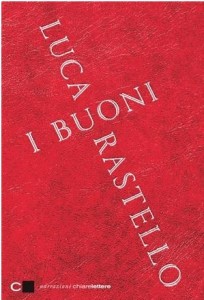 l primo romanzo di Chiarelettere ha aperto il dibattito sulla gestione delle Onlus. E il suo autore è al centro di recensioni e critiche più disparate da parte di chi vuole scorgere la realtà dietro una storia di fantasia.
l primo romanzo di Chiarelettere ha aperto il dibattito sulla gestione delle Onlus. E il suo autore è al centro di recensioni e critiche più disparate da parte di chi vuole scorgere la realtà dietro una storia di fantasia.
E’ un romanzo sul mondo delle Onlus e su cosa c’è dietro a queste organizzazioni. Ma soprattutto I Buoni di Luca Rastello è il primo titolo della collana Narrazioni che ha segnato il debutto di Chiarelettere, casa editrce partecipata dal gruppo Gems, nel genere romanzo. Rastello, giornalista, per molti anni ha lavorato nel volontariato e conosce bene quel mondo. Per questo c’è chi ha voluto leggere la sua storia romanzata come reale, legando ai nomi di fantasia a personaggi reali. Primo fra tutti Don Silvano che Adriano Sofri sulle colonne del Foglio, ha indicato come molto simile a Don Luigi Ciotti, ispiratore e fondatore del gruppo Abele. Da quel momento, era il 26 marzo 2014, Rastello e il suo libro sono stati al centro di critiche e recensioni più disparate.
L’autore ha deciso di ripondere con la sua verità sul romanzo, in una lettera indirizzata al Fatto Quotidiano qui riportata.
Caro direttore,
ci tengo davvero a ringraziare Il Fatto Quotidiano per l’attenzione che ha voluto dedicare al mio romanzo “I Buoni”, e sono lusingato per la lettura attenta e profonda di Daniela Ranieri. Sento però il bisogno di rispondere, sia pure sommariamente, agli attacchi di Nando Dalla Chiesa e Gian Carlo Caselli che sorprendentemente trovo scomposti. I loro articoli su di me sono ricchi di allusioni e insinuazioni sgradevoli, veri e propri insulti (“ipocrisia”, “velo farisaico” già nell’incipit, “volgare”, “squallido”, “arrogante”, “presuntuoso” qua e là) e per di più si appoggiano a riferimenti testuali del tutto scorretti, e in qualche caso addirittura immaginari, che mi costringono a ripetere un vecchio e trito adagio: prima di parlare di un libro conviene leggerlo, e tanto più se si vuole essere efficaci nel distruggerlo. Addirittura Dalla Chiesa inventa una storia d’amore fra un sacerdote e una donna che nel libro proprio non c’è. Capisco l’intento polemico: deve ridurre il libro a una massa maleolente di pettegolezzi (lui dice “gossip”). Mi dispiace perché stimo Dalla Chiesa per le sue battaglie civili e politiche, ma scivoloni come questo mi danno agio per rispedire al mittente il “gossip”: è una forma mentis che forse appartiene a lui, non a me. Quanto a Gian Carlo Caselli, fa finire il romanzo con un’altrettanto inventata “feroce uccisione di un collaboratore di Ciotti” da parte di uno “psicopatico” (l’unico che muore è un personaggio appartato, per me il portatore dei valori più  positivi del romanzo, e muore per mano di un amico). Difficile non pensare che il libro sia stato loro raccontato in maniera assai approssimativa. Ciò non esime però l’ex procuratore dalla psicoanalisi in contumacia: “ipotizzo un risentimento privato profondo”. E perché? Quali torti avrei subito? O la requisitoria intende sostenere che lo psicopatico sono io? Tutta l’aggressività di cui sono oggetto nasce da un’interpretazione suggerita da Adriano Sofri su “Il Foglio” con un’operazione a mio parere eccessivamente meccanica di identificazione fra un personaggio del romanzo (non il protagonista) e don Luigi Ciotti. “Un attacco – nell’oratoria di Caselli – alla persona, al suo pensiero, alla sua opera”. È vero che, una volta pubblicato, un libro appartiene al lettore, e Sofri lo è, che ha il diritto di offrire la sua chiave, ma da qui a voler fare del romanzo un’inchiesta travestita, per codardia o altri loschi e occulti intenti, ne corre assai. Ovviamente nessuno è tenuto a conoscerlo, ma credo che tutto il mio passato possa parlare per me: quando ho voluto fare inchiesta (che fosse su guerra, mafia, narcotraffico, alta velocità, servizi segreti o serial killer) l’ho fatta, guardando tutti negli occhi e facendo i nomi delle persone coinvolte, a chiarissime lettere. E quando ho voluto scrivere un pamphlet (per esempio sugli scrittori che dissertano di democrazia sui giornali) l’ho fatto con nomi e cognomi in chiaro. Molti sassi ho lanciato, mai nascosto la mano, mai fatto velo con eufemismi, travestimenti o retoriche. La scelta di scrivere un romanzo è tutt’altra cosa: è la scelta di affrontare temi generali, se non universali, che riguardano prima di tutto i lati oscuri di chi scrive. Ho voluto raccontare un male che è ovunque e che io per primo porto dentro (se c’è un personaggio a chiave ne I Buoni è forse il solo Andrea, costruito su di me e sulle mie potenzialità più negative). Credo che una condizione decisiva per scrivere qualcosa d’interessante, oltre che di moralmente sorvegliato, sia partire sempre dall’analisi impietosa di sé stesso. Così, ascoltando la lezione di giganti a cui non intendo paragonarmi, posso dire ad alta voce e a fronte alta: Don Silvano sono io. E credo che Don Silvano lo siamo tutti, almeno in potenza, non importa se personaggi pubblici e privati. Certo, la mia vita, le mie esperienze, ciò che ho visto, vissuto entrano a far parte della materia con cui costruisco una storia. È così per chiunque scriva narrativa. Ad esempio nel romanzo precedente era centrale la figura di mio padre, senza che il libro ne fosse una biografia. Il dibattito letterario sul “non fiction novel” data ormai da mezzo secolo (caro Dalla
positivi del romanzo, e muore per mano di un amico). Difficile non pensare che il libro sia stato loro raccontato in maniera assai approssimativa. Ciò non esime però l’ex procuratore dalla psicoanalisi in contumacia: “ipotizzo un risentimento privato profondo”. E perché? Quali torti avrei subito? O la requisitoria intende sostenere che lo psicopatico sono io? Tutta l’aggressività di cui sono oggetto nasce da un’interpretazione suggerita da Adriano Sofri su “Il Foglio” con un’operazione a mio parere eccessivamente meccanica di identificazione fra un personaggio del romanzo (non il protagonista) e don Luigi Ciotti. “Un attacco – nell’oratoria di Caselli – alla persona, al suo pensiero, alla sua opera”. È vero che, una volta pubblicato, un libro appartiene al lettore, e Sofri lo è, che ha il diritto di offrire la sua chiave, ma da qui a voler fare del romanzo un’inchiesta travestita, per codardia o altri loschi e occulti intenti, ne corre assai. Ovviamente nessuno è tenuto a conoscerlo, ma credo che tutto il mio passato possa parlare per me: quando ho voluto fare inchiesta (che fosse su guerra, mafia, narcotraffico, alta velocità, servizi segreti o serial killer) l’ho fatta, guardando tutti negli occhi e facendo i nomi delle persone coinvolte, a chiarissime lettere. E quando ho voluto scrivere un pamphlet (per esempio sugli scrittori che dissertano di democrazia sui giornali) l’ho fatto con nomi e cognomi in chiaro. Molti sassi ho lanciato, mai nascosto la mano, mai fatto velo con eufemismi, travestimenti o retoriche. La scelta di scrivere un romanzo è tutt’altra cosa: è la scelta di affrontare temi generali, se non universali, che riguardano prima di tutto i lati oscuri di chi scrive. Ho voluto raccontare un male che è ovunque e che io per primo porto dentro (se c’è un personaggio a chiave ne I Buoni è forse il solo Andrea, costruito su di me e sulle mie potenzialità più negative). Credo che una condizione decisiva per scrivere qualcosa d’interessante, oltre che di moralmente sorvegliato, sia partire sempre dall’analisi impietosa di sé stesso. Così, ascoltando la lezione di giganti a cui non intendo paragonarmi, posso dire ad alta voce e a fronte alta: Don Silvano sono io. E credo che Don Silvano lo siamo tutti, almeno in potenza, non importa se personaggi pubblici e privati. Certo, la mia vita, le mie esperienze, ciò che ho visto, vissuto entrano a far parte della materia con cui costruisco una storia. È così per chiunque scriva narrativa. Ad esempio nel romanzo precedente era centrale la figura di mio padre, senza che il libro ne fosse una biografia. Il dibattito letterario sul “non fiction novel” data ormai da mezzo secolo (caro Dalla  Chiesa: non ho inventato niente, purtroppo), ma anche prima di Truman Capote gli autori facevano delle loro vite materia narrativa. Signori, mi dispiace ma stavo scavando in me, nel mio lato oscuro. È falso che io abbia voluto raccontare la storia di “Libera”, ho scritto e vedo uscire questo libro in una fase molto difficile della mia vita, una fase in cui si fanno i conti con sé stessi e non con la cronaca. Con sé stessi e con ciò che si lascia ai figli. Il dottor Caselli, che pure dimosta di aver letto la nota dell’editore (eh sì, dell’editore) in apertura, non ha colto nella stessa pagina la dedica (questa in effetti mia) alle mie figlie, “perché sfuggano”. Al male connaturato agli umani, che tanto più è pericoloso per i ragazzi che generosamente si espongono in quelle realtà dove l’incontro fra ottime intenzioni, carisma, narcisismo, potere, relazione di aiuto e modello impresa crea una miscela pericolosa e in certi casi letale su cui è bene tenere sempre uno sguardo critico. Quanto a “Libera”, ho dedicato per più di quattro anni tutto il tempo delle mie giornate e molte notti, con passione e grandi responsabilità, alla sua nascita (anche se oggi il ritocco sovietico alla foto ufficiale mi qualifica “osservatore partecipante”, secondo la definizione involontariamente umoristica di Dalla Chiesa) e vi ho incontrato alcune delle persone migliori della mia vita. Niente secondi fini, cari amici, niente “provocazione intellettuale” o baggianate simili: non mi appartengono e meno che mai mi interessano in questo momento. Una cosa vera la dice Nando dalla Chiesa: che quel che racconto ne I Buoni è vero di tantissime realtà organizzate, antiche come il Pci e Lotta Continua, così come contemporanee. E addirittura non scorge la contraddizione in cui lui stesso cade anche quando ricorda sul suo blog (ed è giusto che lo si ricordi) che proprio quel don Ciotti che secondo lui dovrebbe essere l’oggetto della mia presunta critica ha appena urlato a Latina le stesse cose che penso io e che emergono dal mio racconto a proposito delle associazioni. Ma tant’è, lo scatto irriflesso dell’insulto indica che ho toccato qualcosa di molto molto permaloso, vedo. Fin troppo facile parlare di nervi scoperti. Se la coda è di paglia che bruci, ma non mai per una fiamma accesa da me. Capitò ad autori ben più grandi di me, come Bianciardi che dovette scontare fino alla fine dei suoi giorni la cattiva coscienza di Gian Giacomo Feltrinelli che si era voluto riconoscere nel “Moro” raccontato nella sua Vita agra. Non è indispensabile che il dottor Caselli abbia una buona opinione del libro, né che lo legga, né che intervenga sulle sue questioni di fondo, ma almeno avrebbe potuto dire qualcosa sui temi che anche don Ciotti affronta e che, sia pure in superficie, nel romanzo ci sono. Per esempio l’esistenza di una carità operosa e discreta a fianco e nelle crepe degli imperi caritatevoli, o il dramma del marketing e della professionalizzazione che scavalcano le motivazioni etiche e la gratuità dell’impegno, le manomissioni linguistiche e retoriche, i rituali di sottomissione delle comunità chiuse dove anziché la religione o la morale laica si celebrano culti pagani del Capo. Cose così. Ma lui preferisce usare a sproposito la battuta volgarissima pronunciata da un mio personaggio (serve a connotarne il maschilismo ed è volutamente grottesca) per insinuare surrettiziamente che essa rappresenti il punto di vista dell’autore sul mondo che racconta. Mah. Sono peccatore, reo confesso e come tale non in grado di fare la morale a nessuno, ma mi impegno a non soffocare mai i dubbi, in primo luogo su me stesso. È una questione di ginnastica mentale e morale e un metodo per non assomigliare ai «dottori della legge che sprofondano sempre più nella loro cecità interiore, privi di umiltà e di dubbi» di cui proprio domenica, commentando il vangelo di Giovanni, ha parlato Papa Francesco. Spero almeno mi sia risparmiata una lettura dietrologica anche di questa replica. Anche se si rinnoveranno attacchi e sarcasmi non aggiungerò altro. La violenza dell’insulto confortata da firme importanti ha già iniziato a trasformarsi sui social network in espressioni di vero odio e addirittura non manca chi incita all’azione nei miei confronti. Eppure il dottor Caselli accusa me di invocare manganelli, roghi e manifestare nella figura di un personaggio del romanzo che lui definisce tout court “psicopatico” certe oscure volontà di vendetta (Ripeto: contro che cosa?). Ovviamente non è richiesta al bagaglio professionale di un magistrato la capacità di capire le metafore. Ma il finale del romanzo, che Gian Carlo Caselli (forse con un riflesso, questo sì, professionale) legge come un’istigazione al linciaggio, è invece una metafora che ora posso a cuore saldo applicare a me stesso e ai miei illividiti accusatori: arriva per tutti, immancabilmente, un dies irae. Il mio non è neanche fra molto e io so, con coscienza serena e pulita, che il loro sarà peggiore.
Chiesa: non ho inventato niente, purtroppo), ma anche prima di Truman Capote gli autori facevano delle loro vite materia narrativa. Signori, mi dispiace ma stavo scavando in me, nel mio lato oscuro. È falso che io abbia voluto raccontare la storia di “Libera”, ho scritto e vedo uscire questo libro in una fase molto difficile della mia vita, una fase in cui si fanno i conti con sé stessi e non con la cronaca. Con sé stessi e con ciò che si lascia ai figli. Il dottor Caselli, che pure dimosta di aver letto la nota dell’editore (eh sì, dell’editore) in apertura, non ha colto nella stessa pagina la dedica (questa in effetti mia) alle mie figlie, “perché sfuggano”. Al male connaturato agli umani, che tanto più è pericoloso per i ragazzi che generosamente si espongono in quelle realtà dove l’incontro fra ottime intenzioni, carisma, narcisismo, potere, relazione di aiuto e modello impresa crea una miscela pericolosa e in certi casi letale su cui è bene tenere sempre uno sguardo critico. Quanto a “Libera”, ho dedicato per più di quattro anni tutto il tempo delle mie giornate e molte notti, con passione e grandi responsabilità, alla sua nascita (anche se oggi il ritocco sovietico alla foto ufficiale mi qualifica “osservatore partecipante”, secondo la definizione involontariamente umoristica di Dalla Chiesa) e vi ho incontrato alcune delle persone migliori della mia vita. Niente secondi fini, cari amici, niente “provocazione intellettuale” o baggianate simili: non mi appartengono e meno che mai mi interessano in questo momento. Una cosa vera la dice Nando dalla Chiesa: che quel che racconto ne I Buoni è vero di tantissime realtà organizzate, antiche come il Pci e Lotta Continua, così come contemporanee. E addirittura non scorge la contraddizione in cui lui stesso cade anche quando ricorda sul suo blog (ed è giusto che lo si ricordi) che proprio quel don Ciotti che secondo lui dovrebbe essere l’oggetto della mia presunta critica ha appena urlato a Latina le stesse cose che penso io e che emergono dal mio racconto a proposito delle associazioni. Ma tant’è, lo scatto irriflesso dell’insulto indica che ho toccato qualcosa di molto molto permaloso, vedo. Fin troppo facile parlare di nervi scoperti. Se la coda è di paglia che bruci, ma non mai per una fiamma accesa da me. Capitò ad autori ben più grandi di me, come Bianciardi che dovette scontare fino alla fine dei suoi giorni la cattiva coscienza di Gian Giacomo Feltrinelli che si era voluto riconoscere nel “Moro” raccontato nella sua Vita agra. Non è indispensabile che il dottor Caselli abbia una buona opinione del libro, né che lo legga, né che intervenga sulle sue questioni di fondo, ma almeno avrebbe potuto dire qualcosa sui temi che anche don Ciotti affronta e che, sia pure in superficie, nel romanzo ci sono. Per esempio l’esistenza di una carità operosa e discreta a fianco e nelle crepe degli imperi caritatevoli, o il dramma del marketing e della professionalizzazione che scavalcano le motivazioni etiche e la gratuità dell’impegno, le manomissioni linguistiche e retoriche, i rituali di sottomissione delle comunità chiuse dove anziché la religione o la morale laica si celebrano culti pagani del Capo. Cose così. Ma lui preferisce usare a sproposito la battuta volgarissima pronunciata da un mio personaggio (serve a connotarne il maschilismo ed è volutamente grottesca) per insinuare surrettiziamente che essa rappresenti il punto di vista dell’autore sul mondo che racconta. Mah. Sono peccatore, reo confesso e come tale non in grado di fare la morale a nessuno, ma mi impegno a non soffocare mai i dubbi, in primo luogo su me stesso. È una questione di ginnastica mentale e morale e un metodo per non assomigliare ai «dottori della legge che sprofondano sempre più nella loro cecità interiore, privi di umiltà e di dubbi» di cui proprio domenica, commentando il vangelo di Giovanni, ha parlato Papa Francesco. Spero almeno mi sia risparmiata una lettura dietrologica anche di questa replica. Anche se si rinnoveranno attacchi e sarcasmi non aggiungerò altro. La violenza dell’insulto confortata da firme importanti ha già iniziato a trasformarsi sui social network in espressioni di vero odio e addirittura non manca chi incita all’azione nei miei confronti. Eppure il dottor Caselli accusa me di invocare manganelli, roghi e manifestare nella figura di un personaggio del romanzo che lui definisce tout court “psicopatico” certe oscure volontà di vendetta (Ripeto: contro che cosa?). Ovviamente non è richiesta al bagaglio professionale di un magistrato la capacità di capire le metafore. Ma il finale del romanzo, che Gian Carlo Caselli (forse con un riflesso, questo sì, professionale) legge come un’istigazione al linciaggio, è invece una metafora che ora posso a cuore saldo applicare a me stesso e ai miei illividiti accusatori: arriva per tutti, immancabilmente, un dies irae. Il mio non è neanche fra molto e io so, con coscienza serena e pulita, che il loro sarà peggiore.









