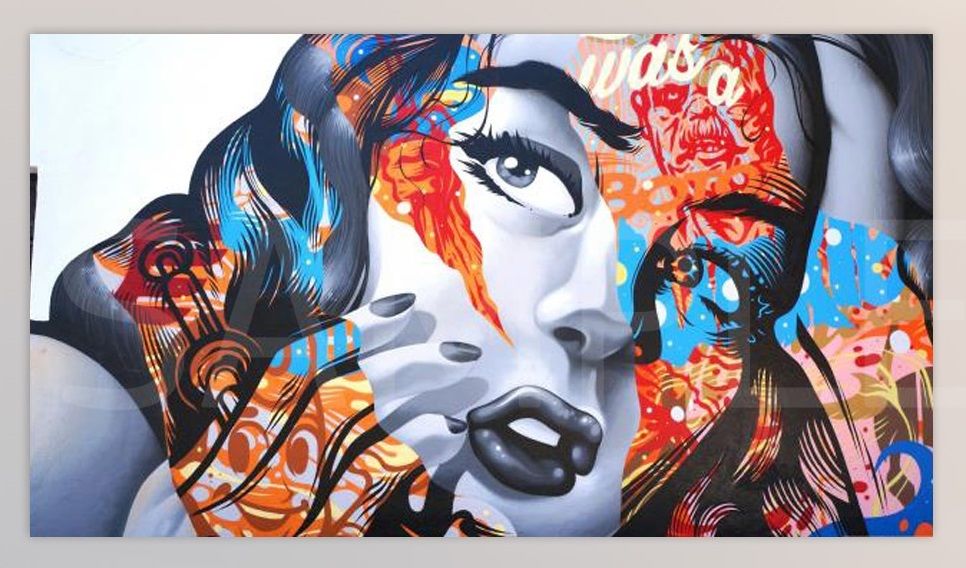Nel tunnel di Lea Paiella_Roma
_Racconto finalista Premio Energheia 2018
Non sapevo come, quando né perché fossi capitato lì dentro. Eppure, c’ero e camminavo dritto verso
il fondo oscuro di quella gola.
Sui muri nessuna indicazione né segnaletica né altro che potesse aiutarmi a capire. Tremavo avvolto
dall’umidità e dal gelo che i mattoni emanavano. L’unica consolazione era per me, in quel
momento, la luce che mi illuminava attorno quanto bastava per capire dove mettere i piedi. Potevo
vedere i mattoni delle pareti ai miei fianchi, fino a quando, troppo lontane, non svanivano
nell’oscurità.
Era curioso. Vedevo intorno a me alte mura inarcarsi verso la cima che mi impedivano di osservare
il cielo, lo sporco incrostato tra ogni mattone ma non una sola fonte di luce. Né foro nel muro né
faretto. Eppure sì, potevo vedere la via come se qualcuno al mio fianco mi stesse facendo strada
lungo quel tunnel con una lanterna in mano.
E camminavo.
Camminavo e i miei passi risuonavano tra le pareti di quell’interminabile buco nero.
“C’è qualcuno?”.
Nessuna risposta. La domanda echeggiò per qualche istante prima di venir inghiottita dall’oscurità.
Poi, d’improvviso, mentre mi riempivo le orecchie dell’unico suono presente in quel luogo, quello
dei miei passi, giunsi a un’agghiacciante e atroce conclusione: mi ero perso.
Forse scontata, ma in quel momento fu la deduzione più terrificante che potessi trarre. Non
conoscevo quel luogo, quelle pareti, quel tunnel. Ignoravo dove terminasse, dove mi stesse
portando. Ignoravo, persino, come fossi giunto lì. Iniziai a chiedermi se, davvero, ci fosse stato un
punto di inizio. L’istante in cui mi ero inoltrato in quel tunnel tornando a casa dal lavoro. Non lo
ricordavo. Se realmente vi era stato, nella mia mente, adesso, costituiva solo un’enorme voragine tra
la fitta rete della mia memoria. Poteva somigliare, ironicamente, a quella verso cui stavo andando
incontro.
Ma un inizio doveva esserci stato. Non potevo capacitarmi del contrario.
Un trauma cranico, decisi. Ero caduto battendo la testa: questa era la ragione della mia perdita di
memoria. E mi aggrappai a quella convinzione con falso soddisfacimento.
Camminavo.
Inesorabile verso un’immensa bocca spalancata. Come un martire che va incontro a una morte certa,
come un bambino forzato ad una vita non voluta e ignota.
In quel momento, in cammino e alla ricerca di un punto di arrivo, mi sentii come il neonato che ero
stato cinquant’anni prima. Impaurito, disorientato e sbigottito. In quel momento, cinquant’anni
prima, davanti a me si era presentato lo stesso buio profondo che adesso si spalancava di fronte ai
miei occhi. E mi sentii piccolo e terrorizzato come quando da ragazzo mi inoltrai in una strada di
campagna in piena notte. Disorientato come allora, davanti a quell’immenso nulla. Il vuoto che si
estendeva davanti a me era diventato, in quel momento, anche parte di me. Potevo sentire l’eco
dell’oscurità rimbombare tra le pareti del mio corpo e mi sembrò quasi di sentir tornare indietro le
parole pronunciate poco prima: “C’è qualcuno?”. Così come quella notte, a diciannove anni, mi
aggrappai alla fioca luce dei fari che veniva inghiottita dopo pochi metri dalla nebbia nera
dell’oscurità.
Perso. Era così che mi sentivo. Solo, in una vastità così immensa da non poter vedere la fine.
Questo pensavo con il nodo della cravatta stretto al collo. E continuai a pensarlo quando
camminando raggiungevo mia moglie all’altare. Lei bianca, io nero come quell’oceano che avevo
dentro. E, camminando, il nodo della cravatta si faceva più soffocante, la camminata più rigida, il
volto più sudato. Il vuoto. Lo vidi quel giorno, il giorno del mio matrimonio. E anche quel giorno mi sentii piccolo. Il neonato che ero stato e che ero ancora adesso. Terrorizzato e impietrito. Perché
l’ignoto, il vuoto, era sempre stato la mia più grande paura.
Camminavo.
E non mi rendevo conto di aver cominciato a trascinare i piedi. Che ogni passo si faceva più pesante
ma, allo stesso tempo, più consapevole. Di cosa, non saprei dirlo. Vedevo la voragine incombere di
fronte a me e realizzai, lì, di esserci già dentro. Totalmente.
Fino a quel momento, mi ero illuso di stare solo in procinto di inoltrarmici. Ogni mio passo era un
passo verso quella profonda gola nera. E così era stato dieci minuti prima e la mezz’ora ancora
precedente.
La verità era che non stavo camminando verso la voragine, stavo camminando all’interno di essa.
Mi voltai. Dietro di me si estendeva minaccioso e paralizzante lo stesso identico nulla che mi
aspettava dinanzi.
Accerchiato. Senza accorgermene, privo di lucidità, mi ero ritrovato inghiottito ancor prima di
esserne consapevole. E mi ricordai di quando, ormai sulla soglia dei quaranta, mi ero ritrovato nella
stessa situazione. Accerchiato. Migliaia di fogli inchiostrati sulla scrivania, la luce del computer che
mi accecava al buio dell’ufficio. Non l’avevo voluto. Eppure, in neanche un anno, ero stato
inghiottito.
Scoraggiato e oppresso. Vinto. Più mi voltavo in cerca di una via di uscita più l’unica cosa che
riuscivo a vedere davanti a me, enorme e ostile, era il vuoto. Prendevo fiato. Non l’avevo voluto. Né
lì, in quel tunnel, né vent’anni prima, in quell’ufficio. Avrei voluto fare il pilota. Era questa l’unica
cosa a cui ero capace di pensare. Avrei voluto fare il pilota fin da quando a cinque anni costruivo
aeroplanini con la carta. Avrei voluto volare e vedere le nuvole scomporsi trafitte dal vento. Avrei
voluto annegare lì, nel blu del cielo e nel suo silenzio. Felice. Lo pensavo mentre battevo le dita sui
tasti del computer e le occhiaie mi arrivavano alle guance.
Non l’avevo voluto. Né lì, né allora. Ma entrambe le volte me ne resi conto troppo tardi. Quando
ormai il vuoto che mi attendeva alla fine del tunnel non stava solo di fronte ai miei occhi, ma dietro,
di lato, sopra al mio volto e sotto ai miei piedi. E naufragavo in quell’oscurità impenetrabile e tanto
densa da sentirla scivolare sulla pelle. Vischiosa, venina giù dalle pareti senza emettere suono.
Camminavo. E non sapevo più da che parte andare. Se davanti a me c’era la fine del tunnel o stavo
percorrendo la strada a ritroso. E più camminavo più mi sembrava che non avrei rivisto la luce.
Mi sentii morto. Forse era nella mia stessa tomba che mi trovavo. Mi sentii vuoto, io stesso. Vuoto
e sperduto. Come ero sempre stato nella mia intera esistenza. Timoroso.
Risi. Sì, forse ero morto. E in questa mia morte non facevo che provare esattamente ciò che avevo
sempre provato in vita.
Nel buio, come una derisoria allucinazione, riuscii a sentire la voce del mio superiore che mi
ordinava di accelerare i tempi. E il pianto di un neonato che trema di terrore.
Avevo paura. Perché per l’ennesima volta nella mia vita non sapevo dove andare. Quale sarebbe
stata la mossa più saggia. Come affrontare questo ostacolo per me insormontabile.
Mi sentii allibito, come quando mia moglie mi chiese di firmare il divorzio. E non importava quanto
io l’avessi amata né quanto amassi mio figlio. Firmai. Con le mani tremanti e la bocca asciutta.
Paralizzato. Ebbi paura anche quella volta e la ebbi ancor di più la sera stessa, tornato dal lavoro e
la casa sgombra. Il vuoto. Era lì, nel letto di mio figlio e sul cuscino di mia moglie. Ed era stato lì,
nella mia testa, per tutto quel tempo. Solo ora potevo vederlo. Che mi invitava a proseguire, inerme,
verso di lui.
E, arrivato a quel punto, fui solamente capace di fare ciò che c’è di più umano per una persona in
difficoltà. Piansi. Come da bambino nelle braccia di mia madre. Mi teneva stretto nel suo profumo
di lavanda accarezzandomi i capelli. Chiudendo gli occhi potevo sentirlo scivolare nelle narici e me ne ubriacai per qualche istante. L’oscurità mi teneva stretto. Nascosto. Era mia madre che mi
consolava nel pianto.
Solo allora, avvolto in quell’abbraccio ingannevole, tutto mi si mostrava più familiare. E quel tunnel
non somigliava più a un luogo umido e tetro come era stato all’inizio del mio cammino. Adesso,
standolo a guardare, prendeva le sembianze della culla in cui da neonato mi mettevano a dormire, la
sedia su cui per cinque anni sedetti alle elementari, il letto di mia madre in cui mi nascondevo
durante un temporale, le braccia possenti di papà che mi stringono al mio compleanno, gli occhi di
mia moglie al nostro matrimonio, le mani di mio figlio che avvolgono le mie sul cammino verso
scuola.
Era questo e molto altro. Milioni di attimi di vita si susseguivano davanti ai miei occhi e
incastrandosi l’uno con l’altro andavano a creare un unico grande complesso cupo e tacito: un
tunnel.
Era lì, la mia intera esistenza. Potevo vederla, sentirla e toccarla ad ogni mio passo. Non dovevo far
altro che proseguire.
Camminavo. E per la prima volta in cinquant’anni di vita, non ebbi paura. Non mi sentii estraneo,
emarginato. Ciò che c’era in quel tunnel, qualunque cosa fosse, mi apparteneva.
Camminavo e vedevo dritto di fronte a me il vuoto. Immenso come all’inizio del mio cammino.
Eppure, adesso, la sua vastità suscitava in me pace. Una quiete mai provata.
Ora sapevo. Che c’era una fine. Come per ogni immensurabile ostacolo che nella vita mi ero creato.
Come per ogni piacere o dolore. Dovevo andare avanti, trascinare i piedi, ascoltare il rumore di quel
nulla. Mi ci sarei perso dentro, un’altra volta e un’altra volta ancora. Minuscolo nel vuoto
sconfinato.
Camminavo.