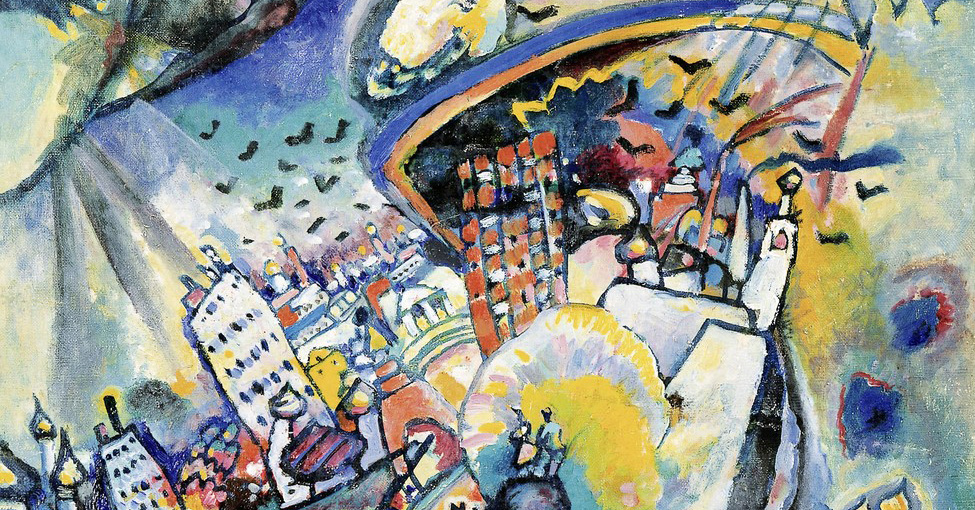Se ‘esperire criticamente il reale’ non è più e affatto un valore condiviso – I parte
Partendo dai temi trattati in un recente numero della rivista “alfabeta2” un’ampia riflessione di natura filosofica sulla presente, preoccupante deriva dei beni e delle attività culturali nell’Italia del populismo berlusconiano (e tremontiano) che ne farebbe volentieri a meno. Le accuse che dal fronte delle élites dell’arte vengono mosse al governo scambiano, però, per cecità quello che è un preciso e sistematico disegno politico che si svolge sotto l’oggidiana egemonia della ‘sfera dell’economico’. È soltanto opponendo con forza un discorso di autonomia della ‘sfera della cultura’ che sarebbe possibile avanzare richieste e rivendicazioni in modo non subalterno.
di Alberto Scarponi
 A quei duemilacinquecento lettori che, fra i milioni che hanno comprato Il nome della rosa, l’hanno poi anche letto è noto che tale romanzo non ha un happy end. Dall’ecpirosi o forse armageddon, da quel rogo terminale, stoico o apocalittico che sia, il monaco scrittore non cava che rovine, flashback e frammenti verbali sopra supporti corrosi dal fuoco. Di qui Umberto Eco, di fede empirista baconiana, cava a sua volta, ma soft, un riscontro filosofico: della rosa che c’era solo il nome ci resta (e ce lo dice citando un esametro dal sapore millenarista: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus). Se dunque delle cose soltanto le parole che ne parlano ereditiamo, noi umani, ora soli nell’universo, beh teniamo prezioso questo unico nostro bene: le parole, il discorso sopra, insomma la cultura. A dire il vero, postmodernamente (il postmoderno dice sempre tutto il vero, per associazione discorsiva, anche quando nel discorso è di troppo), oggi sappiamo, e da Eco stesso, che lì, citando da una citazione, s’era intrufolato un refuso, che in verità abbiamo perduto solo Roma e non la rosa, la realtà. Sì certo, però perfino per chi ha perduto il Paradiso, l’Eden, Eva, l’Eterno e tanto altro ancora, Roma è comunque meglio di niente. Resta sempre una parola, un nome, un verbo… un pezzo di cultura appunto.
A quei duemilacinquecento lettori che, fra i milioni che hanno comprato Il nome della rosa, l’hanno poi anche letto è noto che tale romanzo non ha un happy end. Dall’ecpirosi o forse armageddon, da quel rogo terminale, stoico o apocalittico che sia, il monaco scrittore non cava che rovine, flashback e frammenti verbali sopra supporti corrosi dal fuoco. Di qui Umberto Eco, di fede empirista baconiana, cava a sua volta, ma soft, un riscontro filosofico: della rosa che c’era solo il nome ci resta (e ce lo dice citando un esametro dal sapore millenarista: stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus). Se dunque delle cose soltanto le parole che ne parlano ereditiamo, noi umani, ora soli nell’universo, beh teniamo prezioso questo unico nostro bene: le parole, il discorso sopra, insomma la cultura. A dire il vero, postmodernamente (il postmoderno dice sempre tutto il vero, per associazione discorsiva, anche quando nel discorso è di troppo), oggi sappiamo, e da Eco stesso, che lì, citando da una citazione, s’era intrufolato un refuso, che in verità abbiamo perduto solo Roma e non la rosa, la realtà. Sì certo, però perfino per chi ha perduto il Paradiso, l’Eden, Eva, l’Eterno e tanto altro ancora, Roma è comunque meglio di niente. Resta sempre una parola, un nome, un verbo… un pezzo di cultura appunto.
Ma ecco che nel 2011 accade che il troppo stroppi. Tutto crolla, pure la cultura in rovine. È crisi planetaria. Millenarista? Eonica? Beh, al quel punto, il magister Eco scrive una lettera al minister competente, probabilmente contando sulla forza etimologica degli avverbi originari (magis e minus, a quanto teorizzava – me testimone – il latinista doc Ettore Paratore, credendo anche lui nelle parole). Tuttavia avverbio non è verbo. La lettera viene sì pubblicata dalla migliore quindi maggiore rivista culturale del momento in Italia, alfabeta 2 (nel n. 6), ma nel silenzio tombale del disinteressato ministro suddetto, Giulio Tremonti, mentre il ministro de nomine, l’effettivo de cuius, tira congruamente le cuoia burocratiche (sit venia verbo, siamo nel regno della verbigerazione of course) con un’altra lettera, questa di dimissioni ossia di suicidio funzionale. Tale minister è talmente de cuius, comunque, che la lettera ora citata, pur materialmente scritta a suo dire con tante buone intenzioni (destinate a lastricare il solito cammino, si sa), ha aleggiato lunghissimamente inconoscibile fra i fatti fantasmatici della neorealtà (detta reality) di cui ora si parla.
Dove l’economico si crede culturale ed è crisi
Interviste hanno sopperito alla lettera scomparsa esplicitando per esempio che nella sua ministerialità il rimator beato e intervistato Bondi non ha mai chiesto fondi, mai, bensì solo «riforme strutturali» (toh!), essendoché la cultura «in Italia si regge solo sul ruolo dello Stato» e, insomma, com’è ovvio oggi, quel ruolo non aveva da esistere, bisognava sopprimerlo in toto o giù di lì. Solitudine globale del ministro. Il de cuius era diventato salvognuno «oggetto di tutte le critiche della sinistra», scagliatasi retrograda all’attacco (magari!) «contro le riforme di segno liberale» (vulgo contro la cultura industrializzata d’ogni assortimento) che lui lungimirava a introdurre, e mannaggia senza però riuscire «a convincere pienamente il governo», anche lui un po’ de cuius, del ruolo strategico che può avere la cultura in un Paese come l’Italia». Conclusione afflitta: «E su questo forse la colpa è anche mia». Unico punto dove pare apparire un barlume di coscienza realistica: come si fa infatti a credere di poter affermare il ruolo strategico di qualcosa che si ritiene talmente fuori ruolo da aver bisogno, per esserci, di piedistalli e pilastri, piedritti e zoccoli, a farla breve, di benevolenti beneficienze e favori e favoritismi da tutte le parti? Giustamente il buon Bondi si ravvede e confessa di non aver capito.
E però pure il magister Eco ha, diciamo, ceduto ai tempi: come si fa a scrivere al ministro dell’economia per parlare di cultura? Eco empirico lo fa perché di questo sembra trattarsi hic et nunc, del fus, dei tagli al fus, del cinema e di tutto lo spettacolo italiano lasciato povero e nudo, quasi fosse filosofia, davanti allo specchio della propria povertà (economica). Così, rinunciando a parlare di cultura qua talis, vuole convincere l’economista che la cultura, in quanto consumo e produzione, è un valore economico, gli americani ci «fanno un sacco di soldi», e vuole convincere il politico influente che il mito dell’intelligencija può battere la cultura delle veline, può produrre più influenza politica. Eco perciò è caduto nolente nella stessa trappola di Bondi volente: quella di accettare la trasvalutazione di tutto in nichilistico valore economico. Eppure uno dei rudimenti della tecnica retorica è che accogliere le premesse dell’interlocutore implica rimanere impaniati dentro i suoi sillogismi. Tanto più, poi, quando il discorso, da gioco semasiologico, ha bisogno di farsi proprio filosofico. Più che di un dialogo fra economia e cultura, – essendo ormai questione di vita o di morte, – qui di scontro fra mondi si tratta. Il clima infatti è pessimo, c’è buio e grigio, l’incazzatura è tremenda (oh com’è tremenda) e qui rischiamo tutti di finire nel salotto delle anime belle a fare le statuine clamanti in tv a fini di audience. Il meglio che produrremmo, allora, sarebbe un niente, un dolce far niente. Oggi che perfino lo Zeitgeist non è più lui se non produce un prodotto, il nostro invece sarebbe un dolce nonnulla, la rammemorazione soave del tempo andato.
Il peggio sarà poi figurare, nel contesto, da arraffattori ma incapaci, cioè da fessi, com’è chi non sa farsi valere in un mondo, tutto piccolo-borghese, dove gli assenti hanno sempre torto ed è sensato sapere che volere non è potere, per niente, al massimo è desiderare, mentre potere è sapere, per forza di cose. La stranezza è che tutto scorre mentre noi siamo lì a credere nel progresso come quell’angelo che guardava indietro, pur portando (o solo annunciando?) tempesta.
La causa: il sessantotto (ah! la politica)
Perché è successo tutto ciò? Dev’essere stato il sessantotto. Il sessantotto ha avuto un effetto spaesante. Imponendo la categoria positivistica, naturalistica, di «generazione» come discrimine pratico-teorico assoluto fra orientamenti progressisti o conservatori (Giovane pari a Buono, Nuovo sinonimo di Bene), ha impedito a ciascun individuo di relazionarsi in maniera organica, concreta, al proprio destino effettivo, per poi opporvisi o assecondarlo dentro una propria libera teleologia personale.
Che al contrario la categoria di «generazione» non fosse, politicamente (in tempi di egemonia e autonomia del Politico), decisiva è dimostrato non soltanto di fatto dalla varietà e confusione della diverse carriere personali (militanti o semplicemente elettorali) nei decenni successivi, ma anche dalle ambiguità interpretative che concernono il concetto radice, il sessantotto in quanto tale, nella pubblica opinione. Per evitare di credere che le cose succedono solo qui, diamo un’occhiata fuori casa.
Per esempio in Germania è stato pubblicato un pamphlet (Albrecht von Lucke, 68 oder neues Biedermeier. Der Kampf um die Deutungsmacht, Wagenbach, 2008) dove un politologo presenta il sessantotto addirittura come una sorta di variabile plurisenso, la quale – pur tenendo conto che forse nulla nella storia resiste al lavorio del ragionamento postumo – risulta illimitatamente cedevole, cosa tutta plastica all’uso ideologico (o a quella forza costitutiva della società contemporanea che György Lukács indicò, da ultimo, nel 1968 appunto, con il termine di manipolazione). Cosicché l’autore può descrivere la vicenda politica tedesca di questi decenni come, in sostanza, il processo di formazione di un assetto impolitico ed elitario (dominio delle lobby, a parlamento burocraticamente impotente) fornito di una base sociale costituita dalla massa egemonica della piccola e media borghesia, la middle class, il cui punto di svolta storico sul piano culturale resta bensì appunto il sessantotto, ma contraddittoriamente talora come idea di emancipazione e solidarietà (temi donne, pace, ambiente), talora invece come stolto atto di distruzione di valori necessari (la famiglia, la gerarchia, la cultura intesa come tradizione). È tutta una questione di interpretazione, nel concreto della vita la politica si svuota in polemiche giornalistiche da alterni punti di vista culturali inconcludenti.
È forse interessante, per capire meglio l’Italia, rilevare come tale alternarsi gratuito delle narrazioni (pur piccole) abbia depauperato culturalmente la società tedesca tanto quanto noi lamentiamo sia accaduto a quella nostrana. A prova: nel 2000 il titolo di un libro (Florian Illies, Generation Golf) si diffonde per tutta la Germania ormai intera come etichetta della «generazione golf», che ama l’omonima automobile e, per contro, si sente impoliticamente distratta rispetto alla Guerra del Golfo, che pure nel 1991 ha già aperto il nuovo evo delle guerre del villaggio globale. Naturalmente nello stesso torno di tempo ha successo un altro titolo che, rivolto al femminile, sbandiera adolescenziale il principio (Das Prinzip von Uschi) secondo cui bisogna volere «di tutto solo il meglio» e insegna alle donne «come ottenere quello che vogliono». Inoltre dopo il 1989, con la fine della «repubblica post-nazionale di Bonn», la semantica della generazione cessa di funzionare comunque da sotterranea categoria-base, di qui però un vuoto squilibrante, per cui come riempimento si ha un postmoderno «ritorno della nazione come comunità destinale», per fortuna lieve, soft. La faccenda viene a nudo ai mondiali di calcio del 2006, quando «molto prima del fischio d’inizio è sembrato che gran parte delle chattering classes abbiano fatto a gara a tifare Germania». Il politologo se ne scandalizza, forse impropriamente, e lascia intendere che secondo lui questo abbandonarsi spensierato alla low culture del tifo calcistico è, se non pericoloso, indecente: «Il colmo è stato quando Matthias Matussek, nel libro Wir Deutschen. Warum uns die anderen gern haben können (Noi tedeschi. Perché gli altri possono trovarsi bene con noi), chiarì, così, alla buona, che Hitler e il nazismo non sono stati altro che un caso freak fra i tedeschi». Vero che la frase del sottotitolo è un eufemismo, quasi una litote, che di norma significa: perché a noi degli altri non ce ne può fregare di meno.
La problematicità specifica tuttavia rimane chiusa sotto una parola, Bürgerlichkeit, con cui i tedeschi intendono l’atteggiamento mentale, la cultura, appunto della classe media. Perciò Albrecht von Lücke può concludere domandandosi, un po’ troppo da politologo che sta a guardare, se i ragazzini del XXI secolo apprenderanno a scuola che il sessantotto è stato la nascita della nuova Bürgerlichkeit, cioè dell’apolitico romantico auto innamoramento dell’io, oppure la rinascita del citoyen e della repubblicana vita activa nel senso di Hannah Arendt. Vedremo.